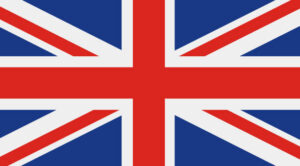Ha fatto di tutto per sottrarcisi, ma dopo lungo assedio il direttore scientifico e co-fondatore della Fondazione, da 54 anni impegnato nella lotta alla fibrosi cistica, cede a un’intervista inevitabilmente incompleta, ma non di meno preziosa.
Perché ha scelto di diventare medico?
Era una cosa che ritenevo di utilità abbastanza immediata, che incontrava il senso di piacere nel servizio. Mi sono laureato nel 1955. Allora il medico era visto come un riferimento. Mi piaceva il suo ruolo nei confronti della gente. E poi la medicina aveva il fascino delle cose misteriose. Mi pareva che il medico dovesse capire di più dell’uomo.
La possibilità di una certa agiatezza non lo interessava?
Una volta il medico non poteva guadagnare molto. La mia fidanzata del tempo (ora mia moglie), quando disse a suo padre, che lavorava in banca, di frequentare uno studente di medicina, si sentì rispondere: «Figlia mia, farai la fame». Davvero non mi ha mai sfiorato l’idea economica.
E così è diventato pediatra.
La pediatria aveva poche conoscenze: sembrava un terreno carico di potenzialità dal punto di vista scientifico e dell’applicazione operativa.
Quali sono stati gli inizi?
Mentre frequentavo la specialità di pediatria presso l’Università degli Studi di Padova, lavoravo all’ospedale di Nogara (VR). Erano i tempi in cui infieriva la poliomielite e i bambini morivano di gastroenterite tossica. Si faceva medicina di frontiera.
All’interno dell’ospedale si era creata una comunità di medici: si viveva insieme ai colleghi delle altre discipline in un gruppo cameratesco. Dormivo e mangiavo là, tornavo a casa la domenica. Fu un’esperienza molto viva e piena, diventata col tempo non più riproducibile. L’avevo comunque vissuta come qualcosa di ristretto: non c’era abbastanza spazio per sfidare e ampliare gli orizzonti.
Quando giunsi all’ospedale infantile Alessandri di Verona, il primario Vittorio Mengoli mi accettò come volontario. Guadagnavo qualcosa facendo visite di supplenza alla mutua. Bastava per vivere.

E la fibrosi cistica?
Nel 1957 incontrai il primo caso. Lì scattò l’interesse. Si trattava di Annamaria, una bambina proveniente dalla contrada Vinchi della Lessinia. Nel 1953, presso la clinica pediatrica di Padova, il prof. Sartori, lo stesso che diede alla malattia il nome non fortunato di «disporia mucoide», ne aveva già studiato un caso, ma se ne sapeva ancora pochissimo. Il gap tra letteratura anglosassone e mancanza di confidenza con la lingua inglese rendeva l’aggiornamento difficoltoso.
Gli americani erano più avanti.
Era il 1938 quando Dorothy Andersen, della Columbia University di New York, fece autopsia a una serie di bambini piccolissimi, emaciati, pelleossa, scoprendo che avevano un pancreas completamente mutato rispetto la sua struttura originale. Il pancreas è formato da acini che secernono gli enzimi che finiscono nell’intestino, ma nei casi in studio gli acini si erano trasformati in cisti collegate tra loro da tessuto cicatrizzale riparativo fibroso. Ecco perché Dorothy Andersen battezzò la malattia «fibrosi cistica del pancreas», per i bambini americani la malattia delle «65 rose», infatti, in inglese, cystic fibrosis suona come sixty-five roses.
Come prosegue la storia?
Nel 1950, in seguito a un’ondata di terribile caldo, a New York morirono molti bambini con fibrosi cistica. Paul Artom di Sant’Agnese, un nostro connazionale ebreo rifugiatosi in America nel 1938, sospettò che fossero morti a causa di una sudorazione eccessiva. Andò a prelevare il sudore dei bambini con FC sopravvissuti e si accorse che conteneva sale cinque volte di più della norma. Era stata la perdita eccessiva di sale a portare al collasso e quindi alla morte i bambini.
Nel 1952, il test del sudore, inventato appunto da di Sant’Agnese, permise d’identificare la FC. Per capire le cause della malattia era molto banale ma molto determinante ingegnarsi su come diagnosticare cose semplici. Gli strumenti per farlo dovevamo inventarceli noi.
Per prelevare il sudore, per esempio, si mettevano i bambini in un sacco di plastica e si dava loro da bere in una stanza calda. Cose barbariche viste a distanza. Nel sacco restava il sudore che si prelevava con una siringa. Furono Gibson e Cooke, un medico e un laboratorista americani, a trovare il modo di indurre la sudorazione in modo poco invasivo.
Torniamo in Italia: quando si superò la fase pioneristica degli studi e della cura della malattia?
Quando le case farmaceutiche iniziarono a produrre estratti pancreatici raffinati e arrivarono i primi antibiotici contro Pseudomonas aeruginosa.
Prima c’è dell’altro.
In laboratorio s’impararono a conoscere funzionalità del pancreas e alterazioni del sangue legate alla malattia. Nacque una sinergia tra gente che aveva diverse professionalità. Ingenuità più buona volontà si sommarono nel tentativo di comprendere di più.
Nel 1967, quando nacque il primo centro italiano di cura della FC a Verona, si erano già maturati competenze e interesse intorno al problema. Infatti nel 1966, a Genova, c’era stato il congresso nazionale di pediatria, il primo evento comunicativo tra pediatri di tutta Italia, in cui si affrontò anche il problema della FC: toccò a me relazionare facendo riferimento a una casistica di 40/50 malati.
I pediatri iniziarono a saper sospettare la malattia, mandando da varie parti d’Italia i pazienti a Verona, dove si faceva diagnosi. Per altro ci si diede presto da fare per contrastare il problema della migrazione dei malati e trovare continuità di assistenza nel loro territorio.
Come faceste fronte all’esodo dei pazienti?
Un aspetto imprescindibile con cui si è lavorato è stata la formazione: crescere imparando e trasmettendo agli altri, ai giovani in particolare, il rigore di un metodo, il continuo aggiornamento e il ricorso alle fonti di conoscenza – i pazienti non ci perdonano l’ignoranza e l’approssimazione –, ma anche lo sviluppo di un modello assistenziale che cresce di dentro e s’incarna nell’organizzazione e nella riscoperta continua del rapporto comunicativo con il malato. In questo le persone che hanno lavorato con me hanno contribuito anche a far crescere altre realtà in altri territori.
A quali principi faceva riferimento il Centro di cura di Verona e come tendeva ad applicarli?
Si perseguiva una modalità di medicina con approccio globale.
I curanti si possono dividono in due categorie: c’è chi cura la malattia e c’è chi cura il malato anche prendendosi cura della sua parte non malata, ma a rischio, e del mondo attorno a lui. Fare diagnosi prescrivendo la cura senza prendersi carico dei problemi pratici è fallimentare. Per farlo bisogna allargare l’orizzonte del proprio approccio professionale, specialmente in caso di malattie croniche e devastanti come questa.
Per noi il malato era prima di tutto una persona che doveva districarsi nei suoi problemi di salute. Per avere a che fare con questi malati e le loro famiglie, per lo più di estrazione povera, bisognava in qualche misura farsi carico anche di ciò che la malattia sconvolgeva nella vita loro e delle loro famiglie. Ai pazienti era importante dedicare tempo, molto tempo. Bisognava saperli ascoltare e sviluppare aspetti di assistenza (anche a casa loro), che non fossero la sola somministrazione di farmaci. In ciò divenne indispensabile un servizio che accostasse sinergicamente le cure mediche al supporto sociale.

Quanti pazienti ha curato?
Ne ho conosciuti e in varia misura curati più di 2000.
Come viveva il fatto di non poterli guarire?
Non sempre il mestiere del medico è quello di guarire, ma è sempre quello di curare. Con la medicina si può sempre ottenere qualcosa. Il medico e il personale sanitario hanno larghissimo spazio per curare, che va dal fare diagnosi al monitorare l’andamento della malattia al prescrivere e somministrare farmaci al preoccuparsi di come il malato viva la sua realtà di malato e s’inserisca nel mondo. Ecco che questo curare assieme assume un significato molto ampio.
Era sottile il confine tra ambito lavorativo e ambito affettivo…
Proprio perché è una malattia che dura da quando nascono fino a quando finiscono stabilisci con questa gente un rapporto particolarissimo, in cui è difficile distinguere il mondo professionale da quello umano fatto di empatie e confidenze.
Quello del medico è un mestiere di equilibrio tra il tecnico e l’umano. Ai medici viene insegnato che la professionalità richiede allo stesso tempo coinvolgimento e distacco: se la mente non è sufficientemente serena per ragionare sui fatti oggettivamente, studiare, valutare le condizioni dei pazienti, non puoi essere utile.
Trovare la felicità nel lavoro con i malati che muoiono è difficile, ma se impari a difenderti per continuare a essere disponibile puoi non perdere attrattiva e passione per quello che fai.
Ci si abitua alla morte?
All’esperienza della morte non è vero che ci si faccia l’abitudine: in qualche misura la vivi come la sconfitta della medicina, ma è soprattutto la perdita di qualcuno a cui ti sei affezionato.
Dove finiscono le cure e inizia l’accanimento terapeutico?
Non può esserci accanimento terapeutico nei confronti di pazienti e genitori che conosci molto bene da anni. Sono tra quelli convinti che si debba adattare il proprio comportamento curativo alle condizioni del paziente, cercando di capire cosa lui o i genitori dei bambini vogliano, per non farli sentire soli, ma soprattutto per contenerne il dolore e la paura.

Nella memoria collettiva c’è un medico che arrivava in reparto in tarda mattinata e lo lasciava a notte fonda. Ha sempre lavorato moltissimo. Quanto il suo ruolo sociale è stato compreso e accettato dalla sua famiglia?
Lì non sono mica su un fronte tranquillo. Bisogna essere molto bravi – e io non lo fui – a contenere un impegno coinvolgente e totalizzante socialmente e contemporaneamente a essere presenti per i figli.
La mia famiglia, mia moglie soprattutto, ha accettato e supportato il mio lavoro, ma non ti senti a posto a livello di sentimento. Una vita fatta senza orari è una libertà che presuppone una schiavitù, perché non hai mai finito, ti si accavallano le cose, non trovi spazio per te stesso, oltre che per la famiglia, e quindi crei un’ingiustizia continua.
Si dice che dietro un grande uomo ci sia sempre una grande donna.
Non mi sono mai sentito un grande uomo. Sempre fortemente impegnato, questo sì. C’è una moglie che mi ha supportato in un modo eccezionale. Non è dietro. È lì. Un monumento.

A parte il lavoro quali sono le sue passioni oltre alla pipa?
Quella è un vizio. Sono da sempre un amante della montagna, delle camminate e dei grandi o piccoli spazi da scoprire; ho coltivato l’arrampicata in roccia fino a quando ho iniziato ad aver paura. Sono innamorato del viaggiare, del conoscere le piccole cose nascoste fuori dai percorsi, della natura e i suoi miracoli. Amo l’arte e la fotografia – ho quintali di foto che percorrono tutta la vita. Coltivo letture molto selezionate. Non sono un mangialibri. Leggo quotidianamente i giornali e mi appassiono alle vicende politiche, con il disagio sempre maggiore del fatto che la nostra è una comunità che non apprezza la politica, non si sente parte viva e responsabile di tutto ciò che abbiamo in comune.
Quando fa i conti con il Tempo, le tornano?
Sono vissuto con l’idea dell’eternità. Non si fa mai i conti con il Tempo, che ha un limite per ogni cosa. La pensione forzata mi ha molto disturbato. Non posso curare i pazienti, ma mi occupo ugualmente di loro. Chissà se questo lo sentono.
Veniamo alla Fondazione FFC: se fosse stato possibile fare ricerca all’interno del sistema sanitario nazionale i progressi sarebbero stati più rapidi?
Lo Stato italiano concede pochissimo alla ricerca e disperde a pioggia i finanziamenti. Comunque, per molto tempo, la sanità pubblica ha dovuto occuparsi di problematiche più comuni rispetto alla FC: aveva bisogno di curare la polmonite. Non c’erano neppure i centri per le coronaropatie.
Però un balzo in avanti si fece, dall’interno, con la Legge 548/93.
La fibrosi cistica è stata in Italia antesignana di un atteggiamento di acculturamento nella conoscenza e nell’assistenza verso la formazione di centri dove fossero concentrate persone che si dedicavano a un problema specifico. La prima legge per la FC, che ideammo insieme a persone illuminate, è stata una pietra miliare nella cultura assistenziale: una strada nuova e più vicina ai pazienti. Divenne un fatto paradigmatico, a cui molti s’ispirarono, perché fece capire che di problemi come la FC ce n’erano molti. Venne applicata prima in Veneto, poi a livello nazionale, quindi gradualmente anche ad altre patologie croniche e soprattutto a quelle povere di conoscenze e interventi assistenziali.
Ha parlato della scoperta del gene CFTR, nel 1989, come di «un momento di svolta molto gasante per la ricerca». Oltre vent’anni dopo a che punto siamo?
Abbiamo delle basi e delle conoscenze molto avanzate, che stanno già mettendo a disposizione cure innovative. La Fondazione è nata e si è sviluppata con l’idea di creare un polo di attrazione per la ricerca intorno alla FC. In giro per l’Italia le professionalità e le strutture scientifiche c’erano; avevamo molte intelligenze e competenze nei campi della biomedicina poco o per nulla utilizzate per la FC. Aprire la porta a bandi annuali per la presentazione di progetti di ricerca è significato coinvolgere un numero crescente di gruppi di ricerca affermati, che hanno iniziato a innamorarsi del problema, a conoscerci, a mettere in comune competenze, formando una rete nazionale di scienziati con ramificazioni internazionali.
La terapia del futuro sarà mutazione-orientata. Ci sarà molto probabilmente una cura specifica per ciascuna mutazione o per ciascun gruppo di mutazioni del gene CFTR che causano la malattia. Siamo in un momento in cui, attraverso la ricerca di base, è possibile nascano rimedi risolutivi almeno per una parte importante dei pazienti. Circa la cura delle complicanze, ci sono tante promesse che arriveranno sicuramente al malato nei prossimi anni. Non è una favola che questa gente sia diventata adulta con un’attesa ed una qualità di vita in continua crescita. Ci sono tante cose che si sono potute fare e si continuano a fare anche prima di aver trovato la cura risolutiva.
A chi va il suo pensiero riconoscente?
Ciò che si è fatto in questi molti anni non sarebbe stato possibile se accanto a me non si fossero aggregate persone generose e molto motivate, che hanno condiviso obiettivi, speranze e fatiche – dico «fatiche» perché la mia memoria ha davanti tutte le difficoltà di ordine umano, tecnico, organizzativo e politico che ogni passo in avanti ha dovuto superare. Alcune di loro si sono perse per strada, altre hanno retto assai bene e alcune lavorano ancora con me: si tratta di medici, operatori sanitari e sociali, pazienti e genitori, anche organizzati in associazioni, dentro e fuori del Centro di cura.
Questa intervista è tratta dal Notiziario n. 32, pubblicato nel dicembre 2011.