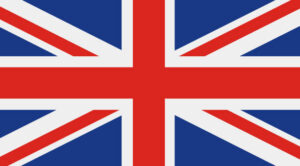Il dottor Riccardo Ciprandi è uno psicologo e psicoterapeuta che lavora presso l’ospedale Gaslini di Genova. L’ultimo progetto di Fondazione sul quale ha collaborato, il #21/2021 La salute psichica nei pazienti affetti da fibrosi cistica: il ruolo prognostico del temperamento, della personalità e degli stili di attaccamento, si è concluso da poco. Un progetto ambizioso e pionieristico, che ha come materia la salute mentale delle persone con fibrosi cistica (FC). Ciprandi fa anche parte del gruppo direttivo di SIFC, Società italiana per lo studio della fibrosi cistica, per la quale è anche coordinatore del gruppo degli psicologi.

Quando sono iniziati i rapporti professionali con Fondazione?
Nel 2019, quando con il team di lavoro dell’Ospedale Gaslini si è deciso di sviluppare la mia tesi di laurea in un progetto di ricerca da presentare al bando di Fondazione.
Qual è stato il punto di partenza per costruire e proporre il suo/ vostro ultimo progetto di ricerca, il #21/2021?
La persona con FC è stata sempre e solamente vista come tale, senza investigare mai le caratteristiche di base della persona. Faccio un esempio. Spesso nei malati FC vengono diagnosticati disturbi dell’umore, quali ansia o depressione, in modalità reattiva, cioè in risposta alla malattia, ma mai si è andato oltre, tentando di capire se ci sono caratteristiche personali che possano contribuire all’insorgere di questi disturbi.
Suona come un grande cambiamento.
Un po’ lo è perché depatologizzare il contesto di cura, ovvero sganciarsi dall’ambito della fibrosi cistica, è funzionale anche alla persona, che scopre così di avere una storia a prescindere dalla malattia. Ognuno di noi ha un temperamento, cioè degli aspetti innati della propria personalità, scritti nel DNA e composti da aspetti biologici: la presenza o meno di una malattia grave non può andare in alcun modo a definirlo. Il progetto di ricerca che ho portato avanti mirava proprio a esaminare come il temperamento, i legami familiari e affettivi e la percezione della malattia stessa, influenzano l’andamento della malattia e l’aderenza alle terapie.
Ha parlato di legami familiari e affettivi. Qual è l’impatto della fibrosi cistica sulla sfera affettiva?
La malattia ha un effetto sul sistema familiare e per questo deve essere gestita ed elaborata in maniera sana. Non è raro che i genitori maturino un forte senso di colpa oppure che l’ansia genitoriale prenda il sopravvento sulla vita loro e su quella del figlio malato o di altri fratelli e sorelle. Tutto ciò è comprensibile perché al momento della diagnosi non viene consegnato – perchè non esiste! – un manuale su come si elabora la malattia. Fin da subito è consigliato affidarsi all’equipe curante, che deve includere anche uno psicologo, che segua i singoli e la famiglia dal momento che quest’ultima è il terreno in cui il bambino, la persona, cresce e apprende gli stili di comportamento che farà suoi per sempre. Più la malattia viene metabolizzata, più il substrato è sano, meno è elevata la probabilità di sviluppare disturbi dell’umore come ansia o depressione.
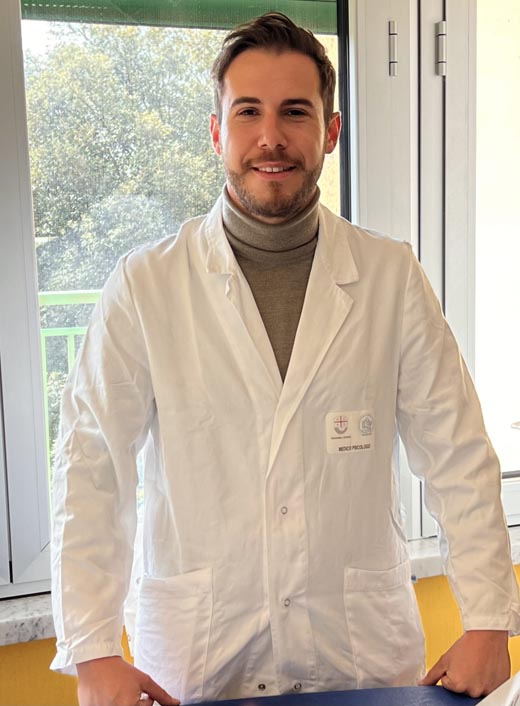
Ha talvolta riscontrato difficoltà nella presa in carico di un malato e/o della sua famiglia?
Certo. Affidarsi a uno psicologo, a una equipe, a una rete, è spesso un progetto lungo. Un genitore, prima di diventarlo, ha una storia propria che deve essere presa in carico. Assistiamo spesso al manifestarsi di uno stato ansioso nei confronti dei medici, di noi psicologi e le relazioni medico-malato, medico-famiglia, possono partire con una certa difficoltà.
La sensazione diffusa è che andare dallo psicologo oggi non sia più un tabù come lo è stato per le generazioni passate. Si sente di confermare?
Da quando esercito la professione, un tempo relativamente breve perché ho 33 anni, ho visto un forte cambiamento. Dal periodo del Covid, soprattutto, in cui molto si è detto sul prendersi cura di sé anche da un punto di vista psicologico, ho notato un maggiore riconoscimento della nostra figura, sia dai malati FC che dal resto della popolazione. Va detto che nell’ambito della fibrosi cistica c’è sempre stata più apertura, ma anche nei pazienti storici, soprattutto nei giovani adulti, ho potuto testimoniare una rinnovata capacità di affidarsi.
La medesima sensazione l’ho provata con i neogenitori che hanno da poco ricevuto la diagnosi: è molto più semplice oggi proporsi e rapportarsi con loro. Sicuramente parlare di psicoterapia, di salute mentale, aiuta a normalizzare e a sentirsi, tutti, meno soli.
Dal 2021 molti malati hanno iniziato ad assumere Kaftrio. Quanto il farmaco ha influito sulla salute mentale di chi lo assume?
Con i farmaci modulatori la qualità di vita è migliorata, ma la risposta psicologica non sempre va di pari passo con la risposta clinica. Nel giovane adulto il miglioramento ha significato mettere, finalmente, in pratica una progettualità scolastica, lavorativa, familiare. Ma tutto ciò ha una grande criticità: molti giovani pazienti con fibrosi cistica non sono abituati a pianificare, non è mai stata data loro la possibilità di farlo, e vanno in crisi. Nell’adulto con fibrosi cistica, invece, la rimessa in discussione della sua vita, che fino a quel momento ha avuto come perno la cura della malattia, lo porta a vivere una nuova giovinezza. Il rischio concreto è di non essere in grado di gestire questa novità e la conseguenza è un forte senso di frustrazione. Il malato di fibrosi cistica giovane adulto o adulto ha dovuto saltare molte tappe sociali e l’adolescenza è stata vissuta solo in parte: vorrebbe tornare indietro, ma la sua età non glielo permette. Si lavora dunque su chi si è, cioè sulla propria identità, che a questo punto prescinde dalla malattia.

Si torna dunque a parlare della persona più che del malato con la fibrosi cistica, dunque al punto di partenza di questa intervista?
Nel percorso di psicoterapia si entra e si esce dalla malattia, toccando le parti più vulnerabili, perché i pazienti sono di nuovo e prima di tutto, persone. Lo sforzo che viene loro richiesto, nel caso dei pazienti che assumono Kaftrio, è enorme: devono reinvestire su loro stessi in ambito lavorativo, familiare, sociale. Inoltre abbiamo osservato il crearsi di uno spaccato di realtà contrastante tra chi ha avuto accesso ai farmaci modulatori e chi, ad oggi, non ha beneficiato di una cura di questo tipo. Ciò ha innescato un senso di esclusione ed abbandono, con dinamiche emotive talvolta particolarmente impattanti, derivanti dal condividere la stessa patologia, ma non poter godere di una qualità di vita positivamente rinnovata, come per molti. Per tutti coloro che, al contrario, hanno sperimentato questa “nuova” fibrosi cistica, vi è stata la possibilità di riscrivere una vita, ma senza dimenticarsi che la malattia c’è ancora, è lì, anche se i sintomi sono più deboli, e che l’aderenza alle terapie deve essere rigorosamente rispettata . In questo senso l’intervento psicologico può costituirsi come estremamente funzionale nella gestione della patologia, lavorando proprio sulla consapevolezza di dover continuare ad affrontare le cure giorno per giorno, nonostante le possibili emozioni contrastanti dettate da condizioni cliniche di benessere.
Ci racconta di una giornata tipo in ospedale?
La fortuna di lavorare in un ospedale come il Gaslini è che non si è mai soli: c’è una connessione proficua e funzionale tra tutte le figure professionali. Ogni giorno inizia con una riunione di equipe alla quale partecipano medici, psicologi, dietisti, e fisioterapisti e questa connessione è utilissima, per noi, e funzionale ai pazienti.
Poi si va in reparto e in ambulatorio, ed ogni stanza, ogni malato, ha il suo bisogno. Ci vuole grande dinamicità mentale perché si passa, per esempio, da un contesto maggiormente propositivo e allegro a uno in cui occorre predisporre grande serietà. Io ho il privilegio di lavorare spalla a spalla con la dottoressa Rita Pescini che si occupa di malati di fibrosi cistica da 30 anni. La cura psicologica qui è partita con lei e grazie a lei ho imparato come avvicinarmi ai pazienti e alla loro storia.
Riesce a staccare una volta finito l’orario di lavoro?
Sto migliorando nel tempo, ma ci sono situazioni di vita talmente impattanti che portarsi a casa niente è una pretesa eccessiva, non sarei tollerante nei miei confronti. Per i casi più complessi è capitato che richiedessi una supervisione, uno spazio di analisi in cui ho portato a un collega più esperto e preparato nel training casi clinici rispetto ai quali ho riscontrato delle difficoltà.
Le andrebbe di raccontarci uno di questi casi?
Un vissuto traumatico è stato la morte di una mia paziente. Avevo iniziato la psicoterapia con lei quando era molto giovane, accompagnandola nel percorso prima del trapianto e l’avevo seguita nel post. Ho fatto una fatica indescrivibile ad accettare che lei dovesse morire: la giornata in cui è mancata la ricordo come un momento devastante. Da questa tragica esperienza ho imparato che si può convivere con il trauma, superandolo e facendolo diventare una risorsa.

Tende a vestire il camice anche nella vita privata?
Sento di avere una lente particolare, critica e valutativa. La sfida è non attivare questi meccanismi professionali fuori dall’ospedale e dall’ambulatorio perché la vita privata serve anche per alleggerirsi.
Cosa fa nel tempo libero?
Amo gli spazi aperti e incontaminati. Ora vivo vicino al mare, ma l’ambiente che mi resetta è la montagna: le passeggiate all’aria aperta sono ossigeno per la mente. Un’altra attività che mi ricarica è mangiare con gli amici: buon cibo e buona compagnia sono un toccasana per tanti momenti no.

Com’è arrivato a scegliere Psicologia?
I miei genitori sono medici, avevo una nonna psicologa, ed uno zio psichiatra e psicanalista. Si può dire che abbiamo la cura nel DNA e che io sono cresciuto tra libri di cultura generale, medicina e psicologia. Ma ho capito poco a poco cosa volevo fare. All’Università Cattolica di Milano avevo inizialmente optato per psicologia del marketing, cioè avevo approfondito l’aspetto comunicativo in ambito aziendale. In apparenza è un inizio molto distante dal punto in cui mi trovo ora, ma in realtà quella preparazione mi sta tornando utilissima in clinica perché mi permette di avere strumenti per approfondire la comunicazione professionista/ medico-paziente: fondamentale nella pratica di tutti i giorni.
E il suo futuro professionale come se lo immagina?
La chiave del progresso in questo ambito è connettere l’assistenza alla ricerca e vorrei ci fossero sempre tante risorse a disposizione per procedere in questo senso. Se potessi esprimere un desiderio molto pratico sarebbe quello di avere un tirocinante, ancor più giovane e quindi fresco di studi di me, con cui portare avanti il lavoro di indagine e di raccolta dati. Il secondo desiderio, più ampio, è di contribuire alla creazione di una rete tra professionisti ancor più fitta e stabile di quella attuale, perché la complessità nel nostro ambito clinico e di indagine sta aumentando e aumenterà sempre di più e la nostra professione deve diventare sempre di più un lavoro di squadra.