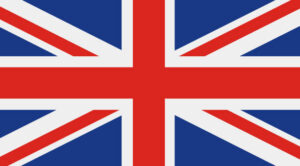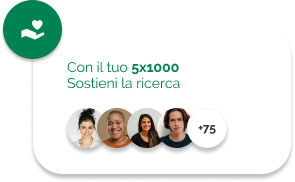Anna Romano, biologa molecolare e divulgatrice scientifica
1 Aprile 2025
Le persone con fibrosi cistica e i loro familiari conoscono di solito fin troppo bene l’impatto che questa patologia può avere sul pancreas. L’insufficienza pancreatica esocrina, presente nella grande maggioranza dei malati, rappresenta non solo una delle manifestazioni più comuni della malattia, ma anche una delle sfide quotidiane più complesse. Come gestirla al meglio, in termini di diagnosi, monitoraggio e trattamento?
Le più recenti linee guida europee sono state da poco pubblicate sulla rivista scientifica Pancreatology: realizzate con il supporto dell’associazione United European Gastroenterology e firmate da un vasto numero di società specialistiche, forniscono le raccomandazioni per la gestione dell’insufficienza pancreatica e in base alle diverse cause, fibrosi cistica inclusa. Diamo un quadro di quanto emerge dal documento.
La fibrosi cistica come causa dell’insufficienza pancreatica
Gli enzimi pancreatici, che comprendono amilasi, lipasi e proteasi (per la digestione, rispettivamente, di amidi, grassi e proteine) sono fondamentali per la digestione dei macronutrienti.
Una percentuale compresa tra il 70 e il 95% delle persone con fibrosi cistica presenta insufficienza pancreatica esocrina, ossia relativa proprio alla produzione di questi enzimi. Sintetizzando il meccanismo che correla queste due condizioni, la fibrosi cistica determina un accumulo di muco nei dotti pancreatici, che ostruisce i dotti e ostacola la secrezione degli enzimi digestivi nel duodeno. Nel tempo, questa condizione porta a un danno progressivo del tessuto esocrino e allo sviluppo di insufficienza pancreatica esocrina (spesso anche endocrina, cioè relativa alla produzione ormonale di insulina), oltre a sintomi e segni quali diarrea, crampi e malassorbimento dei nutrienti e vitamine liposolubili introdotti con l’alimentazione.
Un approccio olistico nella gestione dell’insufficienza pancreatica esocrina
A proposito di quest’ultimo aspetto, vi è un elemento che le nuove linee guida non mancano di sottolineare fin dalle prime righe. Per molto tempo, con il termine insufficienza pancreatica esocrina si è fatto riferimento alla condizione in cui il pancreas non riesce più a produrre i suoi enzimi (o i bicarbonati, anch’essi fondamentali per una corretta digestione).
In realtà, scrivono autori e autrici delle recenti linee guida, l’insufficienza pancreatica dovrebbe essere intesa non come deficit del singolo organo quanto come una sindrome da inadeguata digestione, per la quale il problema non è relativo solo alla mancata secrezione di enzimi ma alla mancata digestione pancreatica, che determina il malassorbimento dei nutrienti. Queste considerazioni portano a suggerire che, nella gestione dell’insufficienza pancreatica esocrina, l’approccio necessario debba essere più olistico rispetto quello tradizionale, cioè debba guardare alla situazione nel suo insieme e non solo ai singoli sintomi o parti del corpo.
Diagnosi e monitoraggio dell’insufficienza pancreatica
La diagnosi rappresenta il primo passo per un trattamento corretto; per questa ragione, la diagnosi di un’eventuale insufficienza pancreatica deve avvenire nel più breve tempo possibile dopo la diagnosi di fibrosi cistica. In effetti, questo è particolarmente importante se si considera che il danno al pancreas insorge molto precocemente (gli studi mostrano che può iniziare a svilupparsi già durante la vita fetale).
Quindi, riportano le linee guida, la valutazione della funzionalità pancreatica esocrina dev’essere effettuata subito dopo la diagnosi di fibrosi cistica; se l’esame è positivo, è raccomandata la conferma dopo tre mesi. Una volta confermata, l’insufficienza pancreatica non necessita di ulteriori test (a meno che non ci siano dubbi clinici).
Nei casi in cui il risultato non sia chiaro, invece, è raccomandato lo stesso monitoraggio richiesto per le persone con fibrosi cistica con sufficienza pancreatica (una limitata percentuale di pazienti il cui pancreas mantiene una funzionalità residua ma che, vale la pena ricordarlo, sono facilmente soggetti a pancreatiti).
Per queste persone, in età sia pediatrica sia adulta, è infatti raccomandato un monitoraggio regolare del pancreas. Il test di riferimento è quello dell’elastasi fecale, un enzima indicativo dello stato di salute del pancreas che può essere analizzato con un esame delle feci. Per i bambini con sufficienza pancreatica è raccomandato il controllo annuale, con ulteriori esami nel caso si presentassero segni e sintomi quali ritardo della crescita, perdita di peso, diarrea persistente e dolori addominali. Negli adulti, invece, il monitoraggio della funzionalità pancreatica può essere personalizzato in base al genotipo CFTR:
- le mutazioni di classe I-III sono considerate ad alto rischio di insufficienza pancreatica ed è raccomandato test annuale;
- le mutazioni di classe IV-VI sono considerate a basso rischio e il test è raccomandato solo in caso di sintomi sospetti.
Quale trattamento per l’insufficienza pancreatica nelle persone con fibrosi cistica?
Per quanto riguarda il trattamento dell’insufficienza pancreatica, nelle persone con fibrosi cistica così come in altri casi, la prima raccomandazione delle linee guida è in realtà più che altro una conferma: dichiarano, infatti, che questa condizione deve sempre essere trattata (altri approcci, come la sorveglianza attiva, non costituiscono quindi un’opzione). Per quanto riguarda il come, si conferma lo standard di trattamento basato sulla terapia enzimatica sostitutiva (Pancreatic Enzyme Replacement Therapy, PERT). La PERT può migliorare peso, stato nutrizionale, sintomi e più in generale la qualità della vita dei pazienti; le dosi iniziali, scrivono autori e autrici, possono variare in base a diversi fattori, come l’età del paziente, la gravità dell’insufficienza pancreatica e il contenuto di lipidi nel pasto. Altri aspetti importanti che vengono ribaditi nelle nuove linee guida sono:
- la PERT deve essere assunta con i pasti e con eventuali snack;
- le formulazioni preferite sono quelle in microsfere (pellet) gastroresistenti.
In caso di risposta nulla o solo parziale al trattamento con PERT, infine, il primo passaggio è verificare l’adeguata somministrazione degli enzimi e l’aderenza alla terapia (valutando anche la steatorrea, cioè la perdita di grasso nelle feci, ndr); in casi specifici, inoltre, potrebbe essere necessario valutare un nuovo dosaggio e/o un trattamento con inibitori di pompa protonica come omeprazolo o pantoprazolo, farmaci che riducono il pH dello stomaco e che possono così contribuire a rendere più efficace la PERT.
In linea di massima, quindi, le nuove linee guida non introducono grandi novità per quanto riguarda il trattamento dell’insufficienza pancreatica nelle persone con fibrosi cistica. Introducono però alcuni elementi importanti per la diagnosi e il monitoraggio della condizione (indicando le strategie personalizzate in base al genotipo, dando priorità al test dell’elastasi fecale per la valutazione della funzionalità pancreatica, ecc). Inoltre, propongono una visione più integrata dell’insufficienza pancreatica come sindrome da inadeguata digestione, non solo da deficit enzimatico. In questo modo, nella fibrosi cistica, dove l’insufficienza pancreatica rappresenta una manifestazione pressoché costante della malattia, offrono da una parte un approccio che conferma l’importanza di una gestione clinica sempre più mirata e specifica; dall’altra, spostano l’attenzione dal mero deficit enzimatico a una visione sistemica del malassorbimento e della gestione nutrizionale.